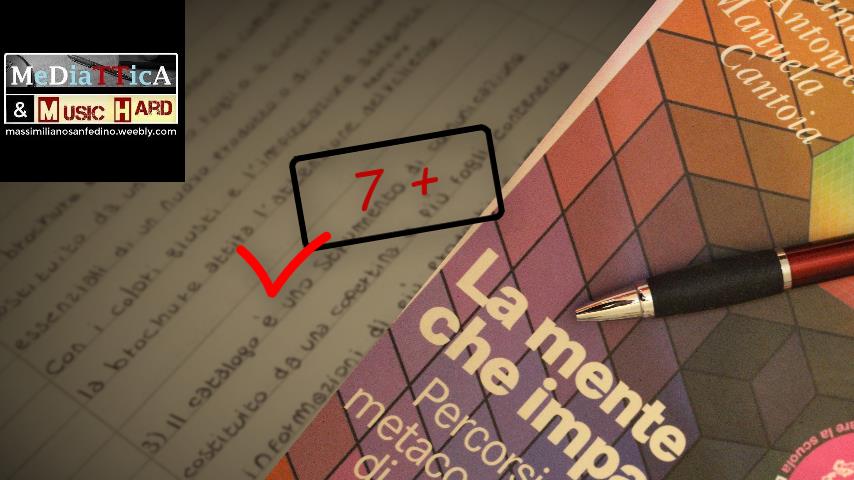... la mediazione didattica ... MEDIATTICALa valutazione scolastica
Dal punto di vista pedagogico-didattico è essenziale definire il nesso intrinseco che esiste fra l’insegnare e il valutare. Di fatto la valutazione è una componente dell’azione didattica, ed essa è continua e inevitabile. In qualche modo, le attività di verifica devono essere pensate e progettate insieme alle azioni di insegnamento. Se ciò non accade insorgono i difetti più comuni e ricorrenti nell’esperienza scolastica: valutazioni superficiali, inadeguate, rivolte ad elementi non dipendenti dall’insegnamento intervenuto, valutazioni giudicate incongruenti o “ingiuste” dagli studenti. La valutazione implica, in primo luogo, una diagnosi, ma questa diagnosi può riferirsi ad almeno tre livelli e dimensioni diverse fra loro: - Si può valutare il quadro generale delle competenze e degli atteggiamenti in atto nella personalità dell’allievo (qualità del linguaggio, conoscenze generali, capacità di concentrazione dell’attenzione e prontezza nell’apprendere, qualità sociali etc.). Dopo un certo periodo di conoscenza dell’allievo, un insegnante "esperto" di norma ha operato una valutazione abbastanza articolata e puntuale di questo livello, in relazione all’età degli studenti. Tuttavia, si tratta di elementi tutti ascrivibili alle pre-condizioni dell’atto di insegnamento e dei processi di apprendimento immediati, e c’è sempre il rischio che il giudizio "sommativo" finale riguardi di fatto tali precondizioni, piuttosto che nuove e specifiche prestazioni cognitive dello studente. - Si possono valutare le potenzialità cognitive ed emotivo-affettive di uno studente (quelle che chiamiamo comunemente “capacità”). Molti insegnanti competenti, con una buona esperienza in alcuni settori scolastici, presentano delle abilità diagnostiche/prognostiche molto sofisticate sotto questo aspetto. Questo tipo di valutazione determina le “profezie” (in positivo o in negativo) che possono influire molto sugli sviluppi futuri dei processi di maturazione dell’allievo e della relazione insegnante/allievo. La “prognosi” ottimistica sollecita aspettative positive nell’insegnante e spesso, per conseguenza, determina le sue stimolazioni e i controlli nei confronti dell’allievo. Tendenzialmente “investiamo” di più su un allievo valutato come “promettente”, come dimostrato dalla ormai classica ricerca sull’effetto Pigmalione). - Possiamo infine valutare (e dunque verificare) gli esiti delle azioni di insegnamento e dei processi di apprendimento rispetto ad unità più o meno ampie di conoscenza e di abilità disciplinari. In questo caso ci riferiamo a periodi e ad esperienze limitate (oggi, una settimana di lavoro, il contenuto disciplinare svolto in un mese etc.). Anche questa è una valutazione (verifica) di tipo diagnostico, ma si applica ad un contesto più limitato e particolare, riguarda una prestazione definita, che può essere del tutto incongruente con le valutazioni del livello generale e delle potenzialità di un allievo, e potrebbe essere incongruente con altre prestazioni parallele in altri ambiti disciplinari. Difatti, è da tener presente che “l’insegnante” quando “entra in classe per tenere la propria lezione” non trova solo “pareti, banchi, sedie, studenti. C’è anche qualcosa che non si vede con l’occhio, ma che influirà su quello che avverrà nell’aula. Oltre allo spazio fisico in cui si tiene la lezione c’è uno spazio mentale: nella testa dell’insegnante e degli studenti ci sono convinzioni, immagini, sensazioni, idee riguardo ciò che capiterà durante la lezione. Insegnanti, studenti, lavagna, quaderni, spiegazioni, interrogazioni si collocano dentro un «ambiente di apprendimento» che è costruito sulla base del modo con cui ci si rappresenta il lavoro scolastico che si compie”[1]. “Il contesto scolastico si definisce appunto come contesto caratterizzato dalla progettualità e dall’intenzionalità delle attività che vi vengono svolte. Si è a scuola per raggiungere obiettivi, e le attività che vengono proposte sono pensate e strutturate per il raggiungimento di un fine”[2]. Inoltre, è indispensabile tenere presente che “oltre alla progettualità degli insegnanti c’è la progettualità dei singoli studenti, che si trovano a dover soddisfare una serie di richieste in termini di conoscenze, comportamenti e risultati”[3]. Presumibilmente, quando uno studente giudica che i suoi professori “fanno differenze” o “fanno ingiustizie”, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti sono effettivamente distratti da “effetti alone”, o da “effetti Pigmalione”, scaturiti dai primi due livelli di valutazione, che interferiscono nella valutazione delle singole prestazioni scolastiche dei loro allievi. Dobbiamo assumere come principio di metodo essenziale la separazione della valutazione di ogni singola prestazione/condotta dalla valutazione della persona. Lungi dall’essere un’indicazione di tipo morale, questo è un criterio professionale specifico: le persone tendono a leggere i giudizi di qualsiasi tipo sempre come riferiti alla propria persona, e dunque se ne difendono anche aggressivamente soprattutto se sono molto giovani. Viceversa, la possibilità di separare la prestazione/condotta dalla propria persona nel momento valutativo è l’unica via per imparare ad utilizzare la valutazione come verifica e come feed-back per modificare le prestazioni successive. Ciò vale anche per gli insegnanti, che hanno sempre grandi difficoltà a valutare le singole attività didattiche (e dunque a modificarle o implementarle) solo perché tendono a identificare se stessi con le proprie prestazioni. Per l’allievo la valutazione dei suoi docenti può avere un effetto predittivo/profetico; agire sull’auto-riconoscimento e sull’autostima, oppure funzionare come una profezia auto-avverantesi. Si può comprendere quindi l’investimento emotivo e la competitività degli allievi riguardo al voto, spesso assolutamente spropositati. Per un altro verso, è evidente che lo strumento standardizzato di valutazione che viene utilizzato (quale che sia), per valutare periodicamente i percorsi di maturazione di ciascuno studente (voti quadrimestrali, finali, voti d’esame) debba essere riconosciuto per definizione come uno strumento sempre imperfetto, sempre “grezzo” e parziale, rispetto alla complessità dei processi in atto nella relazione docente/studente. Le strategie e le scelte più adeguate possono solo ottenere di “ridurre l’imperfezione” dello strumento, per utilizzarlo nel perseguire con maggiore efficacia funzionale gli scopi istituzionali della scuola (cioè la maturazione progressiva personale di conoscenze, competenze, orientamenti e condotte, giudicati socialmente desiderabili). In altri termini: esiste una ‘valutazione’ di natura certificativa, amministrativamente e burocraticamente necessaria, che gli strumenti utilizzati (voti, schede, formulari) tentano di rendere comparabile in prospettive sociali sempre più ampie (il territorio nazionale, la comunità europea). L’idea che questa parte tecnico-burocratica coincida effettivamente con il processo valutativo dagli insegnanti, dentro la relazione con i loro allievi, costituisce una falsa rappresentazione. La natura convenzionale della certificazione deve essere chiarita agli allievi, così come deve essere chiarito, e in qualche modo “negoziato”, in quali termini ciascun insegnante utilizza gli strumenti certificativi in rapporto alla situazione concreta, spingendo costantemente gli studenti a separare il giudizio sulla loro prestazione/condotta dal giudizio sulla persona, imparando progressivamente ad auto-valutare le prestazioni. In conclusione, la valutazione può essere considerata un'opportunità per i soggetti in relazione tra loro, ossia un momento metacognitivo e metacomunicativo positivo? [1] A. Antonietti, M. Cantoia, La mente che impara. Percorsi metacognitivi di apprendimento, Milano, La Nuova Italia, RCS, 2000, p. 42. [2] Ivi, p. 13. [3] Ibidem. Massimiliano Sanfedino |
Categorie
Tutti
Archivi
Gennaio 2021
Massimiliano Sanfedino
- Docente di Tecniche di comunicazione - Specializzato sul sostegno - Blogger - Filosofo e Autore per passione - Webdesigner - Webmaster - Fotoreporter - Redattore web © Diritti d'autore di Massimiliano Sanfedino
Sito di divulgazione delle mie opere Seguimiper restare aggiornato
|
Proudly powered by Weebly