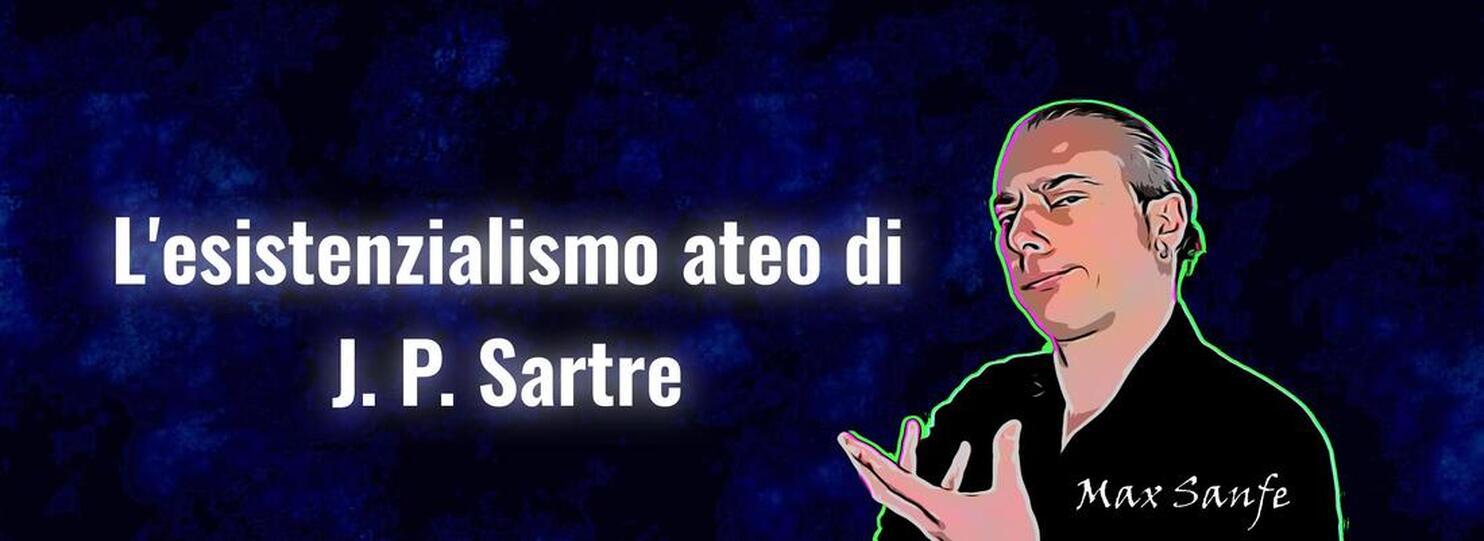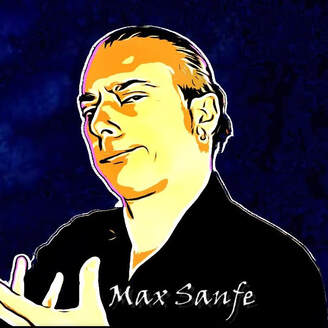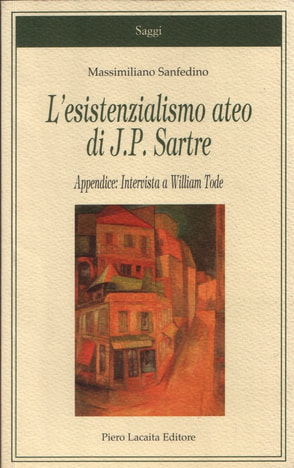
Il Saggio è stato inserito nella Biblioteca del Collegio San Carlo di Modena (organizzatore del Festival della Filosofia), adottato dalla Biblioteca Provinciale "Pasquale Albino" di Campobasso e da varie università d'Italia.
Nello stesso anno è stato inserito nella Bibliographie 2005, a cura di Michel Rybalka, en relation avec le Groupe d'Etudes Sartriennes (GES) de Paris (www.jpsartre.org) e nel 2007 in French XX Bibliography: A Bibliography for the Study of French Literature and Culture Since 1885, a cura di William J. Thompson.
Il 28 Giugno 2005 è stato pubblicato un articolo, relativo al Saggio, nella sezione "Cultura e Spettacoli" del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.
Nel mese di Febbraio 2006 è stato pubblicato un articolo inerente al Saggio su www.riflessioni.it
La rinascita del Sartrismo
Saggista, intellettuale, ateo, marxista: chi è Jean-Paul Sartre?
In un’intervista all’Unità del 15 Aprile 2000, Paola Decina ha messo in risalto che non ha importanza chiedersi se Sartre sia stato più un narratore, un filosofo o un autore di teatro. Ciò che è certo è che Sartre è stato un “uomo secolo”, come dichiara Bernard-Henri Lévy nel suo voluminoso Il secolo di Sartre. L’opera di Lévy incarna quella rinascita del nuovo interesse per il pensiero di Sartre, una nuova fase negli studi sul "sartrismo". Si ode un vento di rinascita, che sia finalmente una SartreRenaissance?
Che sia o meno una vera e propria svolta negli studi su Sartre? Ciò che è certo è che finalmente si respira una nuova aria che potrà aprire sicuramente nuovi orizzonti e campi d’indagine sul "sartrismo".
Oggi resta il ricordo di un “UomoSecolo”, che ancora rivive in molti, come nell’artista mantovano di Arte figurativa William Tode, il quale da giovane ha avuto modo di conoscere il filosofo francese. Jean-Paul Sartre, il maestro di cosa vuol dire essere liberi, il 15 aprile del 1980 naufragava nel suo silenzio: il mondo aveva perso il più grande pensatore dell’Umanismo. Con il suo silenzio, Sartre ha raggiunto il suo obiettivo: si è conquistato finalmente l’eternità. Oggi è vivo, non è solo un ricordo, è sopravvissuto grazie alle sue lezioni di vita. Sartre se lo è scolpito il suo monumento: “Le Parole”, le uniche cose che lo reggono in vita. Anche se per molti Sartre è risultato scomodo, egli è pur sempre il punto di riferimento per il nuovo millennio, grazie soprattutto ad una nuova e più attenta lettura del suo pensiero, che cerca di cogliere il vero significato del "sartrismo".
tratto da L'esistenzialismo ateo di J. P. Sartre
Avevo bisogno di Dio, mi fu dato, lo ricevetti senza capire che lo cercavo. Non potendo attecchire nel mio cuore, egli ha vegetato in me, poi è morto[1].
( J. P. Sartre, Les Mots)
Vi ricordate “di quell’uomo folle che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «Cerco Dio! Cerco Dio! »?[2]. Inequivocabilmente mi riferisco a Friederich Nietzsche, “con il quale si celebra l’inizio dell’ateismo del nostro tempo”[3]. E che dire di quell’uomo che affermava che “il concreto”, in altre parole l’uomo, proiettandosi, non fa altro che creare “l’astratto”, ossia Dio? Non c’é dubbio che io stia parlando del Dio di Feuerbach, quest’ultimo figlio della sinistra hegeliana, il fondatore dell’ateismo filosofico dell’Ottocento, dal quale scaturisce il dilemma se è Dio ad avere creato l’uomo o è quest’ultimo ad avere creato Dio. Per Feuerbach non c’è nessun dubbio che vanifichi il suo giudizio che ad avere creato Dio sia stato l’uomo, come proiezione illusoria e oggettivazione fantastica di qualità umane, poiché, detto in parole sartriane, “l’uomo è fondamentalmente desiderio di essere Dio”[4]. Giovanni Invitto, nel suo Dio: una passione inutile, conclude il suo testo affermando che la risposta al problema dell’inesistenza di Dio è “un ritorno dell’esigenza, già presente in Feuerbach, di interrogarsi sul «perché Dio», se «Dio non è»”[5]. Risposta che ci viene data proprio da Sartre, nel momento in cui egli afferma che l’uomo pensa Dio poiché tende a esserLo, cioè causa sui. Un Sartre che ha come sfondo quella proiezione umana del Feuerbach, di quell’uomo-specchio, il riflesso della sua immagine ideale e divina. Vi ricordate il mito di Narciso, che specchiandosi nell’acqua resta narcotizzato dalla sua stessa immagine? Questo è l’uomo, nel momento in cui celebra la nascita del figlio di Dio. Tutti siamo figli di un essere al di sopra dell’universo: è questo quello che ci hanno fatto credere, una tradizione tramandata sin dalla notte dei tempi, una “folgorante intuizione” - se così si può definire - che nasce dal riflesso trascendentale dell’uomo stesso. L’uomo crea Dio per dare un senso alle cose, poiché non vuole accettare il fatto che il senso sia già dato nelle cose stesse, quella gratuità a cui spesso non sappiamo dare una risposta.
“Tutto è gratuito: questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare […]: ecco la Nausea”[6], ascoltiamo nell’opera teatrale sartriana. Quell’in-sé massiccio, dato, gratuito, non soggetto alla temporalità, alla quale l’uomo ambisce. L’esistenzialismo ateo o “l’ateismo postulatorio”, come lo battezza Gianfranco Morra, ossia quell’ateismo dell’autodeterminazione e della soggettività, trova proprio in Nietzsche “un entusiasta sostenitore”[7]. Per l’ateismo, la coesistenza di Dio e dell’uomo è praticamente impossibile, anzi si escludono reciprocamente, ponendo le basi in quel nietzscheanesimo dell’“autoscavalcamento incessante dell’uomo”[8].
[1] Cfr. Jean-Paul Sartre, Le Parole, Titolo originale: Les Mots [1964], Traduzione a cura di Luigi de Nardis, il Saggiatore, Milano 1972, cit., p. 93.
[2] Cfr. Friederich Nietzsche, Idilli di Messina, La gaia scienza e frammenti postumi 1881-1882, cap. intitolato: «L’uomo folle», versioni di Ferruccio Masini e Mazzino Montinari, Adelphi edizioni, Milano 1965, cit., p. 129.
[3] Cfr. Remo Bodei, I senza Dio, Figure e momenti dell’ateismo, a cura di Gabriella Caramore, Morcellina, Brescia 2001, cit., p. 56.
[4] Cfr. Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, Titolo originale: L’Être et le Néant [1943], Traduzione a cura di Giuseppe Del Bo, il Saggiatore, Milano 1972, cit., p. 680.
[5] Cfr. Giovanni Invitto, Sartre; Dio: una passione inutile, edizioni Messaggero, Padova 2001, cit., p. 71.
[6] Jean- Paul Sartre, La nausea, Titolo originale: La nausée [1938], traduzione di Bruno Fonzi, La biblioteca di Repubblica, Roma 2003, cit., p. 164.
[7] Cfr. Gianfranco Morra, Dio senza Dio, Fenomenologia ed esperienza religiosa, II Ateismo e secolarizzazione, L.U. Japadre editore, L’Aquila, Roma 1989, cit., p. 35. Gianfranco Morra distingue tre forme prevalenti di ateismo: scientifico, postulatorio e della sofferenza, quest’ultimo riferito al pensiero di Camus trattato nel capitolo precedente.
[8] Cfr. L. Stefanini, Esistenzialismo ateo ed esistenzialismo teistico, Cedam, Padova 1952, cit., p. 18.
( J. P. Sartre, Les Mots)
Vi ricordate “di quell’uomo folle che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «Cerco Dio! Cerco Dio! »?[2]. Inequivocabilmente mi riferisco a Friederich Nietzsche, “con il quale si celebra l’inizio dell’ateismo del nostro tempo”[3]. E che dire di quell’uomo che affermava che “il concreto”, in altre parole l’uomo, proiettandosi, non fa altro che creare “l’astratto”, ossia Dio? Non c’é dubbio che io stia parlando del Dio di Feuerbach, quest’ultimo figlio della sinistra hegeliana, il fondatore dell’ateismo filosofico dell’Ottocento, dal quale scaturisce il dilemma se è Dio ad avere creato l’uomo o è quest’ultimo ad avere creato Dio. Per Feuerbach non c’è nessun dubbio che vanifichi il suo giudizio che ad avere creato Dio sia stato l’uomo, come proiezione illusoria e oggettivazione fantastica di qualità umane, poiché, detto in parole sartriane, “l’uomo è fondamentalmente desiderio di essere Dio”[4]. Giovanni Invitto, nel suo Dio: una passione inutile, conclude il suo testo affermando che la risposta al problema dell’inesistenza di Dio è “un ritorno dell’esigenza, già presente in Feuerbach, di interrogarsi sul «perché Dio», se «Dio non è»”[5]. Risposta che ci viene data proprio da Sartre, nel momento in cui egli afferma che l’uomo pensa Dio poiché tende a esserLo, cioè causa sui. Un Sartre che ha come sfondo quella proiezione umana del Feuerbach, di quell’uomo-specchio, il riflesso della sua immagine ideale e divina. Vi ricordate il mito di Narciso, che specchiandosi nell’acqua resta narcotizzato dalla sua stessa immagine? Questo è l’uomo, nel momento in cui celebra la nascita del figlio di Dio. Tutti siamo figli di un essere al di sopra dell’universo: è questo quello che ci hanno fatto credere, una tradizione tramandata sin dalla notte dei tempi, una “folgorante intuizione” - se così si può definire - che nasce dal riflesso trascendentale dell’uomo stesso. L’uomo crea Dio per dare un senso alle cose, poiché non vuole accettare il fatto che il senso sia già dato nelle cose stesse, quella gratuità a cui spesso non sappiamo dare una risposta.
“Tutto è gratuito: questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare […]: ecco la Nausea”[6], ascoltiamo nell’opera teatrale sartriana. Quell’in-sé massiccio, dato, gratuito, non soggetto alla temporalità, alla quale l’uomo ambisce. L’esistenzialismo ateo o “l’ateismo postulatorio”, come lo battezza Gianfranco Morra, ossia quell’ateismo dell’autodeterminazione e della soggettività, trova proprio in Nietzsche “un entusiasta sostenitore”[7]. Per l’ateismo, la coesistenza di Dio e dell’uomo è praticamente impossibile, anzi si escludono reciprocamente, ponendo le basi in quel nietzscheanesimo dell’“autoscavalcamento incessante dell’uomo”[8].
[1] Cfr. Jean-Paul Sartre, Le Parole, Titolo originale: Les Mots [1964], Traduzione a cura di Luigi de Nardis, il Saggiatore, Milano 1972, cit., p. 93.
[2] Cfr. Friederich Nietzsche, Idilli di Messina, La gaia scienza e frammenti postumi 1881-1882, cap. intitolato: «L’uomo folle», versioni di Ferruccio Masini e Mazzino Montinari, Adelphi edizioni, Milano 1965, cit., p. 129.
[3] Cfr. Remo Bodei, I senza Dio, Figure e momenti dell’ateismo, a cura di Gabriella Caramore, Morcellina, Brescia 2001, cit., p. 56.
[4] Cfr. Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, Titolo originale: L’Être et le Néant [1943], Traduzione a cura di Giuseppe Del Bo, il Saggiatore, Milano 1972, cit., p. 680.
[5] Cfr. Giovanni Invitto, Sartre; Dio: una passione inutile, edizioni Messaggero, Padova 2001, cit., p. 71.
[6] Jean- Paul Sartre, La nausea, Titolo originale: La nausée [1938], traduzione di Bruno Fonzi, La biblioteca di Repubblica, Roma 2003, cit., p. 164.
[7] Cfr. Gianfranco Morra, Dio senza Dio, Fenomenologia ed esperienza religiosa, II Ateismo e secolarizzazione, L.U. Japadre editore, L’Aquila, Roma 1989, cit., p. 35. Gianfranco Morra distingue tre forme prevalenti di ateismo: scientifico, postulatorio e della sofferenza, quest’ultimo riferito al pensiero di Camus trattato nel capitolo precedente.
[8] Cfr. L. Stefanini, Esistenzialismo ateo ed esistenzialismo teistico, Cedam, Padova 1952, cit., p. 18.
VEDI ANCHE
|
Web designer Massimiliano Sanfedino - november 2016 - |